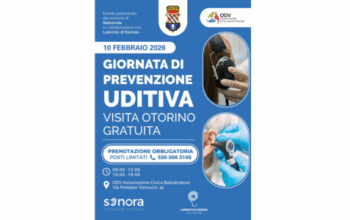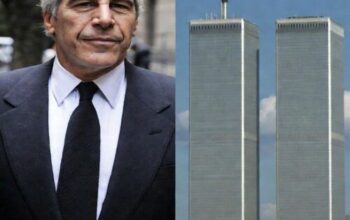Elena Sironi, avvocata e Senatrice del Movimento 5 Stelle ci apre uno scorcio sui suoi lavori in aula. L’urbanistica che torna a popolare le pagine dei giornali a causa delle vicende di Milano offre l’occasione per un ripensamento delle città in cui viviamo come quello che tramite il frenetico lavoro parlamentare, dal suo osservatorio privilegiato, tenta di delineare la Sen. Sironi. L’abbiamo seguita fra le intense e assorbenti giornate in aula, una lotta di emendamenti all’ultimo comma, e convegni pensati per scacciare il torpore e ravvivare il coinvolgimento di una trascurata fetta di società civile a Milano e nella sua Lombardia. (Intervista a cura di Nadir Lehemdi).
Senatrice Elena Sironi, porta il nome di “Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo” il Ddl oggi a firma sua, degli Onorevoli Patuanelli, Di Girolamo e Floridia (AVS) che è all’esame dell’ottava commissione (Ambiente, ecc.). Da dove parte e come procede l’iter di trattazione, qual è l’atteggiamento che si aspetta dalla Maggioranza su questo testo?
Il Ddl 29, attualmente all’esame dell’8ª Commissione del Senato, è in realtà un nuovo testo del relatore (sen. Rosso di FI) che in teoria raccoglie e unifica diversi disegni di legge presentati da più forze politiche, tra cui anche il mio Ddl 1028. I lavori di commissione sono in corso già dal settembre 2023 e nel frattempo ho richiesto ed ottenuto che l’elaborazione del testo passasse dalla iniziale sede redigente a quella referente con un maggior coinvolgimento dell’aula parlamentare; nel corso di questi anni il relatore ha modificato il testo per ben tre volte: oggi siamo infatti al cosiddetto “Testo 2 del relatore”.
Nel corso di questo iter abbiamo già presentato due tornate di emendamenti e, sull’ultima versione, ho personalmente depositato circa 300 emendamenti, perché il testo, così com’è, non mi soddisfa affatto. È fondamentale chiarire che cosa debba intendersi per “rigenerazione urbana”. Per noi del Movimento 5 Stelle rigenerare significa azzerare il consumo di nuovo suolo ed anzi recuperarne alla natura il 20% entro il 20230 ed invertire la tendenza entro il 2050, come prescrive all’art. 8 il regolamento UE 2024/1991 sul Ripristino della Natura negli ambiti urbani; significa favorire il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, recuperare aree degradate e restituire alle comunità spazi vivibili e sostenibili sia dal punto di vista sociale, sia da quello ambientale. Non possiamo accettare che sotto l’etichetta di rigenerazione si nascondano operazioni di mera speculazione immobiliare, deroghe edilizie e urbanistiche mascherate da sostenibilità. Mi aspetto che la maggioranza mostri apertura su questi principi: il nostro contributo è costruttivo, ma fermo nel difendere una visione di rigenerazione davvero sostenibile e nell’interesse dei cittadini.
- – Non è la prima volta che i suoi lavori seguono il solco dei principi e degli obiettivi comunitari. Di questi giorni è la prima Direttiva UE sul suolo, è incoraggiante, non trova? In questo DDL sono pregnanti anche i richiami costituzionali, la Costituzione è spesso una direzione non solo un punto di partenza anche in termini ambientali.
Sì, è incoraggiante vedere che l’Europa, nonostante tutto, stia riconoscendo il valore ecosistemico e strategico del suolo. La nuova Direttiva europea sul monitoraggio del suolo rappresenta un passo importante verso una gestione più consapevole del territorio: introduce per la prima volta un quadro comune per valutare lo stato di salute dei suoli e contrastarne la degradazione, con l’obiettivo di riportarli in buone condizioni entro il 2050.
Questa visione è pienamente in linea con i principi sanciti dalla nostra Costituzione, che dopo la riforma del 2022 con le integrazioni apportate all’art. 9 tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi “anche nell’interesse delle future generazioni”. Ci ricorda che la salvaguardia del suolo non è solo una priorità ambientale, ma un dovere costituzionale, da tradurre in azioni concrete: azzerare il consumo di nuovo suolo, favorire il riuso e il recupero dei suoli degradati, rigenerare senza cementificare e senza impermeabilizzare nuovo suolo.
Su questo stesso percorso si colloca la Nature Restoration Law (Regolamento UE 2024/1991), che dà attuazione pratica a questi principi, fissando obiettivi vincolanti di ripristino: almeno il 20% delle aree terrestri e marine degradate entro il 2030 e tutti gli ecosistemi danneggiati entro il 2050. È quindi essenziale che ogni atto legislativo nazionale — anche quelli non strettamente ambientali — sia coerente con questa visione europea e costituzionale, contribuendo a una governance integrata del territorio che coniughi tutela ambientale, pianificazione e rigenerazione urbana.
In questa direzione si muove la mia azione politica in Parlamento, attraverso emendamenti, interrogazioni e interventi in Aula ed in Commissione.
2. -Il testo della sua proposta non si limita al “saldo-zero” del consumo di suolo, già noto alla dialettica politica, ma si parla di pareggio di bilancio dei servizi eco-sistemici e di invarianza idraulica. Che ci dicono e come si possono normare questi ambiziosi criteri di rigenerazione?
Il concetto di “saldo zero” del consumo di suolo è ormai acquisito nella dialettica politica, ma non basta più. Anche perché si basa su un equivoco in relazione al concetto di consumo di suolo, che non deve essere letto sulla carta dei PGT, ma su una fotografia reale dello stato dei suoli. La vera rigenerazione urbana deve puntare quantomeno ad un pareggio di bilancio dei servizi ecosistemici, cioè alla capacità di ogni intervento di restituire all’ambiente ciò che consuma, in termini di biodiversità, di qualità dell’aria, di gestione delle acque e di resilienza ai cambiamenti climatici.
In questo quadro, il principio di invarianza idraulica e idrologica è altrettanto fondamentale: significa che ogni trasformazione urbana deve essere progettata senza impermeabilizzazione di nuovo suolo e rigenerando il suolo consumato, impermeabilizzato e degradato in modo reversibile.
Questi criteri indicano che la rigenerazione urbana deve diventare un vero processo ecologico, capace di ristabilire l’equilibrio tra ambiente e città. Significa misurare gli effetti degli interventi su suolo, acqua e qualità dell’aria, garantendo invarianza idraulica e pareggio dei servizi ecosistemici. Per renderli operativi servono standard ambientali e indicatori misurabili nei piani urbanistici, che assicurino il recupero dei suoli degradati senza nuova impermeabilizzazione e che rendano la sostenibilità un criterio vincolante, non opzionale, di ogni intervento di rigenerazione. Solo così la rigenerazione potrà essere davvero coerente con gli obiettivi europei e costituzionali.
3. – Colpisce particolarmente l’articolo 7 del suo DDL, che prevede l’obbligatorietà del Piano del Verde, andando a modificare e integrare la Legge del 14 gennaio 2013 n. 10 che disciplina gli spazi verdi urbani. Perché questa norma ribalterebbe il paradigma della pianificazione urbanistica?
Sì, l’articolo 7 rappresenta un punto innovativo del disegno di legge.
Oggi i Comuni possono dotarsi di un Piano del Verde, ma la gran parte non lo fa, con questa norma, invece, il Piano del Verde diventa obbligatorio e soprattutto propedeutico al Piano regolatore generale: significa che non è più il verde a doversi adattare all’edificato, ma l’edificato a doversi conformare al verde. È un cambio di prospettiva profondo: il Piano del Verde diventa la base ecologica della pianificazione, quella che definisce prima di tutto le aree libere, i corridoi ecologici, le cinture verdi, le fasce fluviali e i sistemi di permeabilità del suolo. Solo a partire da questa mappa ambientale potrà essere aggiornato il PRG, garantendo che ogni sviluppo urbano sia coerente con la tutela del paesaggio, la riduzione delle impermeabilizzazioni, la riforestazione urbana e la qualità della vita dei cittadini. In sostanza, l’articolo 7 ribalta il paradigma: non più una pianificazione che “lascia spazi al verde”, ma una pianificazione che parte dal verde come “infrastruttura” fondamentale della città sostenibile.
4. -Un altro punto importante è quello della “Partecipazione” On. Sironi, questo principio che a molti sembra spesso intraducibile nella realtà.
La partecipazione è uno dei pilastri della democraticità dei processi amministrativi e di governo del territorio e per me rappresenta la vera svolta culturale che dobbiamo compiere se vogliamo parlare seriamente di rigenerazione urbana. Non può esistere una città sostenibile se i cittadini restano spettatori. Le comunità devono diventare parte attiva nella definizione delle scelte che trasformano i loro territori, perché solo chi vive quotidianamente un luogo ne conosce davvero le esigenze, le criticità e le potenzialità. Con l’articolo 8 proponiamo di rendere questa partecipazione effettiva, strutturale e tracciabile, non più affidata alla buona volontà dei singoli enti. I Comuni dovranno aprire percorsi di confronto reale con i cittadini, utilizzando strumenti trasparenti e accessibili, piattaforme digitali, portali informativi, incontri pubblici, in modo che ogni piano di rigenerazione nasca da un dialogo aperto e documentato.
L’obiettivo è chiaro: riportare le persone al centro delle decisioni.
La rigenerazione urbana non deve essere una pratica tecnica riservata agli addetti ai lavori, ma un processo collettivo, condiviso, in cui la cittadinanza diventa protagonista della cura e della trasformazione dei propri spazi. Solo così possiamo parlare di rigenerazione vera, democratica e duratura.
5. -Onorevole Sironi, è possibile che nel primo paese in Europa a interdire l’amianto vi sia oggi una stima di 7mila morti all’anno (Osservatorio Nazionale Amianto), più di Francia e Germania? Vanno nella direzione giusta i contributi al suo DDL volti a ridurre gli oneri di urbanizzazione per i soggetti che intervengono con bonifiche o subordinano gli interventi edilizi al requisito della bonifica da amianto e fibre vetrose?
La produzione, la lavorazione e la vendita dell’amianto sono vietate in Italia dal 1992, eppure ancora oggi contiamo migliaia di morti ogni anno per esposizione. È un dato che dovrebbe farci riflettere sulla distanza che ancora separa le leggi dai fatti. Ma proprio per questo dobbiamo essere chiari: la bonifica non può diventare un onere per i cittadini e non deve essere accollata alla comunità con sconti sugli oneri di urbanizzazione che sottraggono risorse ai Comuni.
Il principio deve restare uno: chi inquina paga. È il responsabile dell’inquinamento, non la collettività, che deve farsi carico della bonifica. Ridurre gli oneri di urbanizzazione per chi interviene su aree contaminate può sembrare un incentivo virtuoso, ma in realtà finisce per spostare il peso economico della bonifica da chi ha causato il danno alla comunità. In questo modo si rischia di premiare chi ha tratto profitto da attività che hanno compromesso il territorio.
La rigenerazione urbana deve servire a riparare i danni e restituire sicurezza e salubrità ai cittadini, non a creare nuovi vantaggi per chi ha già compromesso il territorio.
6.- Abbiamo parlato, tramite l’attività parlamentare a farci da filo conduttore, di cosa possa e debba fare la politica. Lei è attentissima alle vicende milanesi che saranno nel bene o nel male esemplari per il resto d’Italia. Che lezione se ne trae? Cosa possono fare i cittadini dai comuni della provincia alle grandi città per rivendicare il rispetto degli ecosistemi e portarlo nell’agenda degli amministratori?
Le vicende milanesi sono emblematiche e devono far riflettere. Mostrano cosa accade quando la pianificazione urbana perde di vista il bene comune e diventa terreno di interessi e opacità. Milano, che potrebbe essere un modello di sostenibilità, rivela invece i limiti di un sistema che non ascolta abbastanza le comunità e le competenze diffuse sul territorio. Le reti civiche, le associazioni e i comitati locali esistono, lavorano con serietà e spirito pubblico, ma troppo spesso restano inascoltati. Il problema non è la mancanza di partecipazione, ma la difficoltà della politica ad aprirsi al confronto e a riconoscere il valore di chi presidia il territorio ogni giorno. Serve una visione diversa: città governate insieme ai cittadini, fondate su trasparenza, condivisione e responsabilità. Solo così la rigenerazione urbana potrà davvero tradursi in equilibrio ambientale e giustizia sociale, invece che in nuove occasioni di speculazione.
Di Nadir Lehemdi