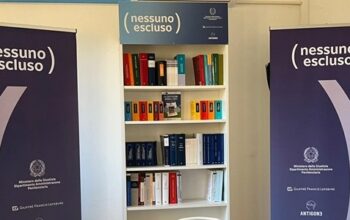Questo ulteriore articolo, integra il precedente in ordine alla recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 27515/2025) che ha riscritto le regole della responsabilità penale in materia sanitaria, affermando che il gravissimo reato di epidemia colposa può essere commesso anche tramite un’omissione. Sebbene presentata come un’evoluzione giuridica necessaria, questa decisione, a un’analisi più attenta, si rivela un esercizio di stile dogmatico, tanto elegante in teoria quanto inapplicabile e potenzialmente pericoloso nella sua applicazione pratica, soprattutto nei confronti del comune cittadino. La pronuncia, infatti, appare pericolosamente scollata dalla realtà fattuale e dalle insormontabili difficoltà probatorie che caratterizzano i fenomeni pandemici.
Una Costruzione da Laboratorio Giuridico
Il cuore della critica risiede nel meccanismo con cui i giudici sono giunti a questa conclusione. La Corte ha riqualificato il delitto di epidemia (art. 438 c.p.) da reato “a condotta vincolata” – che richiedeva un’azione positiva di “diffusione” di germi – a reato “a forma libera”, dove ciò che conta è unicamente l’aver “cagionato” l’evento-epidemia. Questa rilettura ha spalancato le porte all’applicazione dell’articolo 40, comma 2, del codice penale, la clausola che equipara il “non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire” al cagionarlo attivamente.
Tuttavia, questo impeccabile sillogismo giuridico si infrange contro il muro della realtà. Se da un lato la sentenza sembra voler colpire i vertici decisionali (dirigenti sanitari, datori di lavoro), la sua astratta formulazione finisce per creare un’ipotesi di reato fantasma quando applicata al singolo.
Il Paradosso della Quarantena: un’Accusa Impossibile
Consideriamo il caso emblematico del cittadino positivo a un virus che viola l’obbligo di quarantena.
Chiariamo un punto fondamentale sull’azione di commettere un reato
Se un cittadino è sottoposto a quarantena obbligatoria e esce di casa violando il divieto, si configura un reato di commissione.
Perché è un reato di commissione?
- La persona compie attivamente un comportamento vietato dalla legge: uscire dalla propria abitazione durante un periodo di isolamento sanitario.
- La condotta è positiva (cioè un’azione), non una mancanza.
Quindi uscire di casa durante la quarantena è un comportamento attivo che viola un obbligo disposto per legge, quindi è reato di commissione.
Solo facendo una ipotesi in astratto e al contrario, si dovrebbe sostenere in teoria che, la violazione della quarantena da parte del cittadino è una condotta omissiva.
Inoltre, per configurare il delitto di epidemia colposa, l’accusa dovrebbe superare l’ostacolo probatorio, quasi insormontabile, di dimostrare che la condotta di quel singolo individuo abbia causato un’epidemia, intesa come evento massivo, rapido e incontrollato. È praticamente impossibile isolare la condotta di un singolo come causa di un fenomeno così complesso e multifattoriale. Chiedere a un pubblico ministero di provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l’uscita di casa del signor Rossi sia stata la causa diretta di un’ondata epidemica in un quartiere o in una città è una pretesa che sconfina nella fantasia giuridica. Si tratterebbe di una “prova diabolica” che trasformerebbe ogni processo in una farsa, destinata a concludersi con un’inevitabile assoluzione per mancanza di prove.
La Vera Sanzione: Art. 650 c.p., l’Unico Rischio Concreto
Di fronte a questo castello accusatorio destinato a crollare, qual è la vera conseguenza per chi viola l’isolamento? La risposta non si trova né nell’articolo 438 c.p. né, tantomeno, nell’articolo 40, comma 2, c.p. Quest’ultimo, è bene ribadirlo, non è un reato, ma un principio generale che non può fondare da solo alcuna accusa.
La norma concretamente applicabile è, e rimane, l’articolo 650 del codice penale: l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Si tratta di una contravvenzione che punisce la mera disobbedienza a un ordine legittimo dato per ragioni di igiene. Questo reato non richiede la prova di alcun danno o evento successivo; la condotta punita è la semplice violazione del precetto. È una sanzione chiara, proporzionata e, soprattutto, processualmente sostenibile.
La sentenza delle Sezioni Unite, nel tentativo di creare un’arma contro i “grandi” responsabili, ha finito per generare un “mostro” giuridico inapplicabile ai “piccoli” e che rischia di creare solo confusione. Si è costruito un principio giuridicamente perfetto ma fattualmente sterile, che non sposta di una virgola la responsabilità penale del cittadino, ma che potrebbe alimentare aspettative di giustizia irrealistiche e inchieste destinate al fallimento. Invece di fornire strumenti efficaci, la Corte ha partorito una norma-manifesto, più utile per i manuali di diritto che per le aule di tribunale.
Francesco Paolo Cinquemani
*avvocato